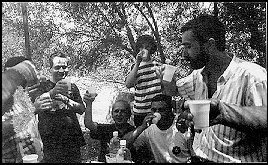
Padre Puglisi insieme ai suoi parrocchiani
di Francesco
Deliziosi
giornalista
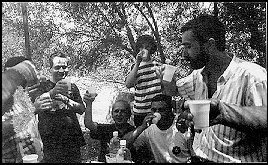 Padre Puglisi insieme ai suoi parrocchiani |
"Coraggioso testimone del Vangelo" di Francesco
Deliziosi |
BIOGRAFIA
Don Giuseppe Puglisi nacque nella borgata palermitana di
Brancaccio il 15 settembre 1937, figlio di un calzolaio e di una
sarta, e venne ucciso dalla mafia nella stessa borgata il 15
settembre 1993, giorno del suo 56° compleanno. La causa per il
riconoscimento del martirio è stata aperta il 15 settembre 1999
- a sei anni dalla morte - per volontà del cardinale di Palermo,
Salvatore De Giorgi.
Don Puglisi avvertì la vocazione sedicenne e grazie ai sacrifici
economici della sua umile famiglia entrò nel seminario diocesano
di Palermo nel 1953. Venne ordinato sacerdote dal cardinale
Ernesto Ruffini il 2 luglio 1960.
Nel 1961 fu nominato vicario cooperatore presso la parrocchia del
SS. mo Salvatore nella borgata di Settecannoli, limitrofa a
Brancaccio, e rettore della chiesa di San Giovanni dei Lebbrosi.
Qui avvia le prime attività per i giovani del quartiere e
sostiene le lotte di un gruppo di abitanti di alloggi popolari
che chiedono al Comune i servizi essenziali. Saranno i due "fili
rossi" del suo impegno per tutta la vita.
Nel 1963 venne nominato cappellano presso l'istituto per gli
orfani "Roosevelt" e vicario presso la parrocchia Maria
SS. ma Assunta a Valdesi, una borgata marinara di Palermo.
Collaborando con l’Azione cattolica continuò anche in
questa nuova zona a seguire in particolare modo i giovani e si
interessò delle problematiche sociali dei quartieri più
emarginati della città.
Seguì con attenzione i lavori del Concilio Vaticano II e ne
diffuse subito i documenti tra i fedeli con speciale riguardo al
rinnovamento della liturgia, al ruolo dei laici, ai valori dell'ecumenismo
e delle chiese locali. Il suo desiderio fu sempre quello di
incarnare l'annunzio di Gesù Cristo nel territorio, assumendone
quindi tutti i problemi per farli propri della comunità
cristiana.
Il primo ottobre 1970 viene nominato parroco di Godrano, un
piccolo paese in provincia di Palermo - segnato da una sanguinosa
faida - dove rimane fino al 31 luglio 1978, riuscendo a
riconciliare le famiglie con la forza del perdono. In questi anni
segue anche le battaglie sociali di un'altra zona della periferia
orientale della città, lo "Scaricatore".
Il 9 agosto 1978 e` nominato pro-rettore del seminario minore di
Palermo e il 24 novembre dell'anno seguente direttore del Centro
diocesano vocazioni. Nel 1983 diventa responsabile del Centro
regionale Vocazioni e membro del Consiglio nazionale.
Agli studenti e ai giovani del Centro diocesano vocazioni ha
dedicato con passione lunghi anni realizzando, attraverso una
serie di "campi scuola", un percorso formativo
esemplare dal punto di vista pedagogico e cristiano.
Don Giuseppe Puglisi e` stato docente di matematica e poi di
religione presso varie scuole. Ha insegnato al liceo classico
Vittorio Emanuele II a Palermo dal '78 al '93.
A Palermo e in Sicilia e` stato tra gli animatori di numerosi
movimenti tra cui: Presenza del Vangelo, Azione cattolica, Fuci,
Equipes Notre Dame.
Dal marzo del 1990 svolge il suo ministero sacerdotale anche
presso la "Casa Madonna dell'Accoglienza" dell'Opera
pia Cardinale Ruffini in favore di giovani donne e ragazze-madri
in difficoltà
Il 29 settembre 1990 viene nominato parroco a San Gaetano, a
Brancaccio, e nel 1992 assume anche l'incarico di direttore
spirituale presso il seminario arcivescovile di Palermo. Il 29
gennaio 1993 inaugura a Brancaccio il centro "Padre Nostro",
che diventa il punto di riferimento per i giovani e le famiglie
del quartiere.
La sua attenzione si rivolse al recupero degli adolescenti già
reclutati dalla criminalità mafiosa, riaffermando nel quartiere
una cultura della legalità illuminata dalla fede. Questa sua
attività pastorale - come e` stato ricostruito dalle inchieste
giudiziarie - ha costituito il movente dell'omicidio, i cui
esecutori e mandanti sono stati arrestati e condannati.
Nel ricordo del suo impegno, innumerevoli sono le scuole, i
centri sociali, le strutture sportive, le strada e le piazze a
lui intitolate a Palermo e in tutta la Sicilia.
A partire dal 1994 il 15 settembre, anniversario della sua morte,
segna l'apertura dell'anno pastorale della diocesi di Palermo. Il
15 settembre 1999 il Cardinale Salvatore De Giorgi ha insediato
il Tribunale ecclesiastico diocesano per il riconoscimento del
martirio, che ha iniziato ad ascoltare i testimoni. Un archivio
di scritti editi ed inediti, registrazioni, testimonianze e
articoli si e` costituito presso il "Centro ascolto giovani
don Giuseppe Puglisi" in via Matteo Bonello a Palermo (091-334669).
LA FIGURA DEL SACERDOTE
"Coraggioso
testimone del Vangelo" l’ha definito Giovanni Paolo II
durante la visita in Sicilia, a Catania e a Siracusa, del
novembre 1994. E per la diocesi di Palermo padre Pino Puglisi -
sei anni dopo il delitto (15 settembre 1993) - è oggi certamente
uno dei punti di riferimento per chi voglia ricostruire un
percorso di vita esemplare come carisma profetico e feconde
capacità educative.
I testimoni, inoltre, in greco antico sono i "màrtyres"
e l’offerta della vita, il martirio, sanciscono nella storia
terrena di padre Pino l’incarnazione fino in fondo dei
valori cristiani in una realtà come quella di Brancaccio,
simbolo delle tante periferie siciliane dove la voce della Chiesa
è spesso l’unica a confortare e promuovere il riscatto
degli ultimi, con il coraggio della denuncia.
Per questo il giorno della morte di padre Puglisi in quanto
momento non di sconfitta ma dell’incontro con il Cristo-vita
è diventato a Palermo il giorno dell’apertura dell’anno
diocesano, attimo simbolico del "kayròs", il tempo
della liberazione e della salvezza.
Padre Pino si sentiva nell’intimo della propria fibra
spirituale di sacerdote persona "consacrata",
sacramentalmente configurata a Cristo pastore della Chiesa. E
dall'amore di Dio promanava l'ansia di verità e di giustizia
sociale che lo ha reso insopportabile agli occhi dei boss mafiosi
a Palermo, così come - lo leggiamo nel Vangelo - l'azione del
giusto è un peso insostenibile per lo sguardo del peccatore.
"3P", come amava farsi chiamare, ha saputo costruirsi
questa valenza profetica attraverso pilastri senza tempo: questi
sono la Fede viva e coltivata nella meditazione della Parola e
nell'aggiornamento teologico, la preghiera personale e liturgica,
la quotidiana celebrazione dell'Eucarestia, la frequenza del
sacramento della Penitenza. E tutto questo nella dimensione di
una vita poverissima: "La benzina è il mio pane", ci
diceva. Il pane poteva mancare alla sua umile mensa, ma non il
carburante per l'utilitaria, in modo da essere sempre pronto ad
accorrere dove una telefonata o un presentimento rendeva
necessaria la sua parola.
In questo articolo cercherò di rievocare chi era padre Pino,
analizzando in particolar modo il suo metodo pedagogico, che ho
potuto sperimentare in prima persona. Al liceo Vittorio Emanuele
II "3P" è stato l’insegnante di religione mio e
della compagna di classe che ora è mia moglie. Ci ha
accompagnato nel nostro cammino di fede e ha benedetto il nostro
matrimonio.
Quando è diventato parroco di Brancaccio, nell’ottobre del
’90, l’abbiamo raggiunto e ci siamo impegnati con lui
nel quartiere. Doveva battezzare nostro figlio Emanuele e ci
metteva fretta ogni volta che ne parlavamo. L’ultima volta
è successo tre giorni prima del delitto. Lui aveva capito che
gli era rimasto poco tempo.
Dalle vicende biografiche passerò al metodo e infine tenterò di
delineare cosa stava facendo padre Puglisi a Brancaccio e il
movente dell’omicidio, rispecchiando quel percorso
educazione della coscienza - educazione all’amore -
educazione socio-politica che è stato indicato come base per la
raccolta di riflessioni nelle varie diocesi siciliane in vista
del Convegno-festa.
"3P" E LA
CHIESA
Don Puglisi ha vissuto profondamente incastonato nella "sua"
Chiesa, ne ha condiviso gioie e tensioni, ne ha saputo precorrere
gli slanci come un pioniere, un pesce pilota. E, insofferente
alle sclerosi della gerarchia, ha sempre rifiutato la logica
della "carriera" negli incarichi diocesani. Quando
qualcuno lo chiamava "monsignore", rispondeva "monsignore
lo dici a tuo padre".
Figlio di un calzolaio e di una sarta, ordinato nel luglio ’60
è arrivato a Brancaccio nell’ottobre del ’90, con alla
spalle quindi trent’anni di sacerdozio e una serie di
esperienze diversissime ma tutte all’insegna del dialogo.
Negli anni Sessanta e Settanta, durante le contestazioni, Padre
Pino parlava con i giovani che si professavano comunisti seduto
al tavolo di una taverna quando in Italia erano feroci le
contrapposizioni tra destra e sinistra. Impartiva catechesi ma
anche educazione sessuale a ragazzi e ragazze insieme quando
persino l'Azione cattolica proibiva certi "contatti".
Fu parroco in diverse periferie della città ma sempre spinse la
sua Chiesa in strada. E cominciò a interrogarsi sul senso della
vita dell'uomo quando il Concilio Vaticano II e le sue
riflessioni esistenziali erano di là da venire. E ancora:
precorse la rivoluzione dell'ecumenismo, dialogando con i
protestanti a Godrano, un paese del Palermitano in cui fu parroco
negli anni Settanta.
Per tutta la vita la sua attenzione, con serenità e pazienza, fu
dedicata all'evangelizzazione, ai poveri, agli umili, alle
persone senza voce e forse senza neanche speranza. Si fece occhio
per il cieco, piede per lo zoppo, si è fatto "tutto per
tutti", per citare una delle riflessioni della Lettera ai
Corinzi che gli era cara.
La gioia e l'allegria di don Pino erano contagiose come il suo
senso della comunità cattolica. Fu responsabile per Palermo e
poi per l’intera regione dei Centri Vocazionali e nei campi-scuola
organizzati nell’ambito delle attività di queste strutture
i sacerdoti diocesani e i religiosi riuscivano a stare fianco a
fianco. Gesuiti, francescani, passionisti...tutti - al di là
delle esperienze precedenti e della diversa formazione - si
ritrovavano nelle sue iniziative in una piena familiarità che
purtroppo ancora oggi è difficile creare all'interno della
Chiesa, spesso così tanto divisa nei rapporti tra i vari Ordini
e le parrocchie.
Padre Puglisi amava la sua Chiesa, come una madre. E infatti
spiegava, con una battuta: "Noi possiamo, dobbiamo criticare
la Chiesa quando sentiamo che non risponde alle nostre
aspettative, perché è giusto cercare di migliorarla. Ma va
sempre criticata come una madre, non come una suocera!".
IL METODO (EDUCAZIONE
DELLA COSCIENZA).
I cinquemila volumi sparsi nell'abitazione di don Puglisi (oggi
la sua biblioteca è stata trasferita al Seminario di Palermo),
al Centro vocazioni o dati ...in "prestito permanente"
agli amici attestano una solida cultura teologica (amava
particolarmente le opere di Karl Rahner, uno dei padri del
Concilio), filosofica (in special modo sul Personalismo del
filosofo francese Emmanuel Mounier) e pedagogica. Freud e Fromm
ma anche Sartre e Maritain: Padre Pino metteva al servizio della
sua sensibilità le più acute riflessioni dell'esistenzialismo e
i più moderni metodi della psicanalisi, della logoterapia e
della terapia di gruppo (tra i suoi autori preferiti anche l'americano
Karl Rogers). Strumenti che utilizzava tacitamente, senza
vanterie, per affinare le notevoli qualità innate grazie alle
quali entrava facilmente e profondamente in contatto con l'Altro
(quella che Rogers nei suoi scritti chiama empatia).
Oltre ai suoi volumi testimonianze preziose sono le decine di
cassette con le registrazioni di suoi discorsi o omelie, che al
Centro diocesano vocazioni stanno ora costituendo un archivio
organico. Da questo materiale sono tratte le citazioni utilizzate
per questo articolo.
Lungo tutta la sua vita don Puglisi ha saputo tessere rapporti
personali fortissimi, a prescindere dall'estrazione sociale, dal
titolo di studio dell'interlocutore: era amico di quelli che
hanno letto un milione di libri come di quelli che non sanno
nemmeno parlare.
La prima fase era l'ascolto. Senza parlare mai di religione o di
Dio, nel delicato momento dell'approccio non dava consigli
immediati, ricette magiche. Sapeva che per usare le parole giuste,
soprattutto con gli ultimi, con i deboli, bisogna prima dividere
a lungo il pane e il vino con loro. In un mondo che corre, dove
ognuno è in fondo perso dentro ai fatti suoi, le grandi orecchie
di don Pino erano un approdo sicuro.
Il percorso dell'ascolto era lungo, tortuoso, poteva anche durare
anni, poteva anche non sboccare da nessuna parte. Padre Puglisi
sapeva ascoltare, rispettava i tempi di tutti, invitava a
scandagliare il proprio animo, per misurare le energie prima di
scegliere un traguardo. "Nessun uomo è lontano dal Signore
- è una delle sue frasi preferite - Lui è vicino, senz'altro,
ma il Signore ama la libertà. Non impone il suo amore, non forza
il cuore di nessuno di noi. Ogni cuore ha i suoi tempi, che
neppure noi riusciamo a comprendere. Lui bussa e sta alla porta.
E bussa. Quando il cuore è pronto si aprirà".
Sul suo stile ha scritto parole illuminanti padre Agostino Ziino
- un palermitano entrato a far parte della comunità monastica di
don Divo Barsotti - in un discorso di commemorazione nel primo
anniversario della morte: "Non era un grande oratore ma un
prete la cui parola, proposta in quel modo tutto suo - con
pacatezza, lentezza di espressione, che non era né impaccio né
imbarazzo - rivelava la volontà di comunicare idee non tirate
fuori frettolosamente e superficialmente, bensì meditate e ben
mirate; non era neppure un uomo dalle manifestazioni e dalle
espressioni vistose, eppure, essenziale com'era nel vivere l'amicizia
come dono di sè agli altri, te lo ritrovavi vicino nei momenti
in cui era bello o utile condividere con lui una gioia o un
dolore.
Lì dove lo incontravi, seppur immerso in attività pastorali di
gruppo o in dialoghi personali o nella preparazione di incontri
di catechesi o di preghiera, ti accoglieva sempre come tu fossi
stato per lui un dono di Dio. E mai ti liquidava frettolosamente,
proprio come se fosse lui a ricevere qualcosa da te, da te che
andavi a lui soltanto per un breve saluto. Il tempo nelle sue
mani si dilatava; ma sarebbe meglio dire non nelle sue mani ma
nel suo cuore, perché solo l'Amore riesce a dilatare gli spazi
interiori del cuore perché si sappia sempre accogliere gli altri
come sapeva fare lui. Ovunque fosse e in ogni momento della
giornata - oserei dire proprio notte e giorno - ti offriva quel
suo sorriso accogliente e rassicurante, che era già in sé
messaggio evangelico di una beatitudine vissuta. Il segreto di
questo suo stile di donarsi agli altri non poteva che essere una
Carità scelta e assunta come atteggiamento costante, a cui
mantenersi fedele, e che rendeva tutto in lui profondo e semplice,
propriamente evangelico".
Quando scoccava una scintilla nell'animo del giovane che don Pino
stava seguendo, alla fase dell'ascolto subentrava quella della
vita comunitaria, dell'apertura del dialogo con gli Altri.
Esempi preziosi di questo lavoro, che riprendeva molte delle
tecniche psicologiche della terapia di gruppo, sono i campi
vocazionali che padre Puglisi organizzò lungo tutti gli anni
Ottanta, prima di diventare parroco a Brancaccio. In un'atmosfera
di piena libertà, senza l'obbligo di indossare "maschere"
per mostrarsi agli altri, i giovani che partecipavano ai campi
erano condotti a scoprire i valori dell'amicizia, della
solidarietà, della fraternità, del servizio, in una parola del
"vivere insieme" nel senso cristiano.
A chi, dopo aver compiuto questo cammino, chiedeva di avanzare
ancora di un passo, padre Pino offriva di slanciarsi nella scelta
di Dio: ognuno di noi - diceva spesso don Puglisi - sente dentro
di sè un'inclinazione particolare, un carisma. Un progetto che
rende ogni uomo unico e irripetibile. Questa "chiamata"
è il segno dello Spirito Santo in noi. Solo ascoltare questa
voce può dare senso alla nostra vita.
LA PASTORALE
VOCAZIONALE (EDUCAZIONE ALL’AMORE).
"Sì, ma verso dove?", era uno degli slogan preferiti
da padre Pino: verso dove vogliamo che vada la nostra vita? In
sintonia con la teologia post-conciliare, don Puglisi applicò,
nel suo rapporto con i giovani, il concetto di "vocazione"
nel senso più esteso: dalla vocazione esclusivamente sacerdotale
si passò alla riflessione esistenziale sulla "chiamata"
che ogni uomo sente dentro di sè e che deve saper interpretare
per venire incontro allo Spirito. Un invito alla meditazione che
è servito da guida alle migliaia di adolescenti che padre Pino
è riuscito ad avvicinare a Cristo. "Bisogna cercare di
seguire la nostra vocazione - ha detto padre Pino - il nostro
progetto d'amore. Ma non possiamo mai considerarci seduti al
capolinea, già arrivati. Si riparte ogni volta. Dobbiamo avere
umiltà, coscienza di avere accolto l'invito del Signore,
camminare, poi presentare quanto è stato costruito e poter dire:
sì, ho fatto del mio meglio. Venti, sessanta, cento anni...la
vita. A che serve se sbagliamo direzione? Ciò che importa è
incontrare Cristo, vivere come lui, annunciare il suo amore che
salva. Portare speranza e non dimenticare che tutti, ciascuno al
proprio posto, anche pagando di persona, siamo i costruttori di
un mondo nuovo".
UN NUOVO MODELLO DI
PRETE E DI PARROCCHIA (EDUCAZIONE SOCIO-POLITICA).
Detto tutto questo, possiamo adesso calarci nello specifico delle
vicende che hanno portato all'omicidio Puglisi (per questa parte
un contributo arriva anche dalle riflessioni di padre Cosimo
Scordato pubblicate sulla rivista della Facoltà Teologica di
Sicilia). E delineare alcune indicazioni che rappresentano un
patrimonio prezioso per una "chiesa di frontiera" come
quella siciliana (anche questa è una definizione del Papa).
C'è innanzitutto da analizzare il motivo dello scontro tra la
mafia e don Puglisi. Don Pino propone a Brancaccio un modello di
prete che i boss non riconoscono, mentre si sono sempre mostrati
pronti ad accettare e "rispettare" un sacerdote che sta
in sacrestia, tutto casa e chiesa, promotore di processioni -
magari al fianco dello "Zio Totò" di turno -, che
"campa e fa campari". Padre Puglisi sceglie invece di
uscire dalla sacrestia e di vivere fino in fondo i problemi, i
rischi, le speranze della sua gente. Desidera in quanto parroco,
la liberazione e la promozione del suo popolo.
Don Puglisi propone inoltre un nuovo modello di parrocchia. Tra
le sue iniziative, ad esempio, c’era la richiesta di una
scuola media a Brancaccio, l'unico quartiere di Palermo che ne è
ancora oggi sprovvisto, è un pungolo per le istituzioni. Da qui
una serie di manifestazioni, di contatti con lo Stato, di
proteste civili. Tutto questo avviene alla luce del sole, lontano
dall'altare, con gesti che per la loro visibilità non passano
inosservati: sono scelte ben precise e compiute con la
consapevolezza del loro effetto dirompente sugli equilibri
mafiosi. "Non dobbiamo tacere", diceva don Pino ai
parrocchiani più timorosi nei giorni delle minacce, degli
attentati che preludevano all'agguato. E aggiungeva, citando San
Paolo, "si Deus nobiscum, quis contra nos?".
Sono scelte che lasciano intravedere l'immagine di una Chiesa che
ha deciso di essere "debole con i deboli", di stare
dalla parte degli ultimi, che crede nelle istituzioni, senza
supplenze o logiche clientelari. Senza supplenze perché la
Chiesa non deve occupare spazi o compiti amministrativi che non
le competono. Senza logiche clientelari, ovvero senza prestarsi
alle pressioni, alle richieste di raccomandazioni e di servitù
al politico di turno (quando a Brancaccio arrivavano questi
ultimi, don Pino li metteva alla porta insieme con i loro
facsimili elettorali).
Hanno ben inquadrato la situazione i giudici della Corte d’Assise
nella motivazione della sentenza (depositata alla fine dello
scorso giugno) che ha condannato all’ergastolo i quattro
imputati accusati dell’omicidio: "Padre Puglisi aveva
scelto di ricostruire il sentimento religioso e spirituale dei
suoi fedeli e di schierarsi concretamente dalla parte dei deboli
e degli emarginati. Era andato oltre la mera solidarietà e aveva
scelto di denunciare i soprusi e i misfatti; aveva gradito assai
poco e anzi scoraggiato l’appoggio offerto alla Chiesa dai
potenti della zona, collusi e compromessi con gli esponenti
locali del potere mafioso e con il ceto politico, facile a certi
compromessi".
Non è facile "educare alla legalità" quando ci si
trova a costruire sulle macerie.
Possiamo qui ricordare un episodio che ha come protagonista
Corrado, un bambino di Brancaccio. Un giorno si presenta da padre
Pino e dice:
"Padre Puglisi, non la posso fare la prima comunione"
E perché?
"Perché oggi abbiamo studiato i comandamenti..."
E allora?
"Ce n’è uno che dice di non rubare. Ma se io non rubo,
se la sera non porto a casa qualcosa, mio padre non mi fa entrare!"
Scrivono ancora i giudici della Corte d’Assise: "La
comunità di Brancaccio in un territorio a prevalente sovranità
mafiosa costituiva un’enclave di valori cristiani, morali e
civili che non lasciava indifferenti i maggiorenti della zona, i
quali a un certo momento di questa sfiancante contrapposizione
decisero di uccidere il prete scomodo".
È questa di Padre Puglisi una chiesa, insomma, che si cala nella
realtà del territorio e dei suoi bisogni: questo è il banco di
prova di una testimonianza che vuole essere veramente evangelica.
E se la Chiesa, tutta la Chiesa, saprà fare propria questa
lezione allora per davvero la figura del piccolo prete di
Brancaccio, caduto sotto i colpi della violenza omicida, non
porterà più su di sè i segni cruenti della sconfitta, ma le
stimmate di una dignità feconda, carica della forza della
risurrezione.